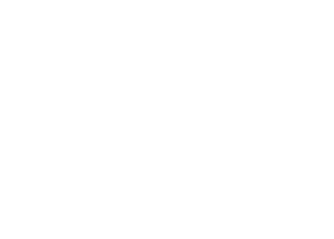Ora che è diventata operativa, la Brexit può finalmente dimostrare se e quanto gravi saranno le conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea sulla tenuta dei posti di lavoro. Non solo in Inghilterra ma anche in Italia. Con l’uscita ufficiale, il 31 gennaio 2020, inizia infatti un periodo di 11 mesi in cui Londra dovrà trovare un accordo con Bruxelles in grado di far funzionare senza scossoni i rapporti tra l’isola e resto dei paesi dell’Unione europea di cui non fa più parte. Gli scenari del no-deal preoccupano molto le imprese, anche se – come ricostruito per Fanpage.it – le minacce di chiusura o abbandono dell’Inghilterra con relative perdite di posti di lavoro per ora sono più di facciata che reali.
Guardando ai dati disponibili oggi, la Brexit potrebbe causare perdite consistenti di posti solo in caso di una totale mancanza di accordo. Ma, lo vedremo, questa ipotesi oltre a essere ancora molto lontana nel tempo, non giova né a Bruxelles né a Londra.
Lo dimostrano anzitutto i risultati di un’analisi pubblicata quest’estate dall’Università di Leuven e diventata virale sui media. La ricerca era stata commissionata dal governo belga per capire l’impatto della Brexit su specifici settori industriali e quindi sui posti di lavoro per aree geografiche maggiormente basate su certi comparti produttivi (come l’automotive o il tessile e la moda). A realizzarlo è stata l’economista Hylke Vandenbussche e lo studio, per ora, non risulta essere stato contestato o criticato in ambito accademico. Per l’Italia si parla, come dato aggregato di ben 139 mila posti persi. Ma quel numero si riferisce allo scenario peggiore, cioè l’uscita senza accordo e con l’applicazione della salate tariffe commerciali applicate agli scambi extra-comunitari nudi e crudi. Un’ipotesi che è sì sul piatto ma scongiurabile non solo nel corso del 2020 ma anche per tutto il successivo anno e in ogni caso realistica solo in caso di tempesta perfetta.
Anche laddove alla fine del 2020 non ci fosse il deal, nel 2021 scatterebbe un regime speciale tariffario voluto dal governo inglese per l’esenzione totale dei costi sull’87% dei prodotti esportati dai paesi come l’Italia verso il Regno Unito. Le stime sulle perdite dei posti sono infatti legate soprattutto al restante 13% di beni appartenenti per lo più a settori chiave (food, automotive) ma su cui si sta lavorando per estendere le stesse agevolazioni.
È quindi falso ritenere che l’Italia perda nel 2020 o 2021 quella quota di occupazione. I numeri più realistici invece sono contenuti nei dettagli sull’impatto della soft Brexit sui singoli settori produttivi.
Così, in condizioni normali e di deal, perderemmo 1656 posti in agricoltura, 1248 nel food&beverage, 4779 posti nel tessile nella moda e dell’industria degli accessori (il settore più colpito), 551 posti nell’industria chimica, 431 in quella farmaceutica, 2378 nei macchinari, 667 nella componentistica automotive, 2207 nei servizi di supporto amministrativo. Ma è lo stesso studio a ricordare che le perdite sono legate a una performance depotenziata della catena di valore prodotta dagli scambi interni all’Ue. Tradotto: la transizione dal Regno Unito da paese sottoposto a regole commerciali ed economiche certe e omogenee (pensiamo ad esempio solo ai trasporti) a paese che deve ridefinire questi equilibri potrà comportare un rallentamento negli scambi con conseguenze sul lavoro. Il punto, quindi, è creare un corridoio di stabilità.
Laddove anche un solo posto perso non è mai una buona notizia, questi dati ridimensionano la portata catastrofica dell’impatto della Brexit e parlano piuttosto della necessità di stimolare la creazione di un mercato del lavoro forte, interno all’Italia e all’Unione europea che, nel complesso perderebbe tra i 280 mila e 1,2 milioni di posti: ma sono responsabilità che riguardano più le politiche interne che quelle inglesi. La Brexit, detto altrimenti, è un fenomeno che va governato e non subito come inteluttabile.
Che il nostro paese sia esposto, non è un mistero. Lo è però un misura inferiore rispetto ad altri stati europei, soprattutto dell’Est (ad esempio la Polonia). Questi scenari sono confermati da un altro studio commissionato sempre da Bruxelles e realizzato dal Comitato delle Regioni nel 2018. Qui le stime confermano un impatto trasversale negativo sull’economia del Vecchio Continente visto che le conseguenze di un aumento dei costi per l’export colpirebbero settori che oggi vivono di globalizzazione, vale a dire: automotive e trasporti, macchinari, elettronica, tessile e arredamento, agroalimentare e materie prime vegetali, industria chimico-plastica. Ma per l’automotive, ad esempio, è la Grecia il paese più esposto in termini di minor introiti (quasi 20 miliardi di euro), mentre l’Italia è tra le regioni che lo sono meno anche se al di sotto dei cinque miliardi di euro. Idem per quanto riguarda i macchinari: come paese sarebbero penalizzate soprattutto le aree produttive del Sud Italia (questo sarebbe il vero impatto da arginare), ma mai quanto la Germania che sull’export ha praticamente fondato la sua forza economica e chiaramente risentirebbe per prima e in modo più eclatante dell’effetto domino innescato da un cambiamento choc nei flussi commerciali in caso di no-deal. Si tratta, sia chiaro, sempre di stime basate su un contesto politico ed economico molto fluido e che non trovano riscontri immediati né nel breve né nel medio periodo.
I posti degli italiani che restano in UK
Quanto al lavoro di chi, italiano o di altra nazionalità europea, viva in Inghilterra, sono i dati sulle domande di pre-settled e settled status a fornire indizi sull’impatto che avrà davvero la Brexit sugli occupati. Si tratta del regime messo in piedi dall’amministrazione inglese per consentire ai cittadini europei di continuare a vivere e lavorare nel Regno Unito non essendo più sufficiente avere la carta di identità o il passaporto di un paese Ue per accedere a lungo termine ai servizi e al mercato del lavoro inglese.
Il 16 gennaio sono state aggiornate le statistiche provvisorie sulle domande (EU Settlement Scheme Statistics). Solo a dicembre le richieste ricevute sono state 163 mila 300.
Alla fine del 2019 il totale delle application eseguite a partire dall’inizio dell’iter per la Brexit (il 28 agosto 2018) ammontavano a 2,7 milioni. Di queste ben 291 mila sono state fatte da italiani, uno dei dati più alti insieme a quello della Romania. “In generale – si legge nella nota che accompagna le statistiche – al 31 dicembre 2019 il numero delle domande portate a compimento (cioè analizzate e licenziate dalla pubblica amministrazione inglese rispetto a quelle ricevute ndr) sono state 2,45 milioni. Di queste il 58% ha ottenuto il settled status e il 41% il pre-settled status (il permesso che si ottiene se non si è in Inghilterra continuativamente da almeno cinque anni ndr)”. Solo sei domande sono state rigettate sulla base della mancanza di idoneità di chi le ha presentate.
Vuol dire che quasi l’80% delle richieste di residenza, provvisoria o permanente, per vivere e lavorare in Inghilterra hanno ottenuto via libera e che praticamente moltissimi italiani che hanno fatto domanda l’hanno ottenuta. Per il momento il cambio di status comporta sì un aggravio burocratico e anche un passo indietro culturale rispetto a un contesto in cui bastava essere cittadini dell’Unione europea per avere libero accesso ai servizi e al mercato del lavoro inglese. Ma non c’è per ora alcun nesso causale tra il mancato ottenimento dei permessi ed eventuali mancati rinnovi di contratti di lavoro.
Prepararsi al peggior scenario è cosa saggia, ma creare allarmismi diffondendo l’idea – non supportata da evidenze – che Londra stia diventando chiusa e irraggiungibile è ancora prematuro. A conti fatti sono invece gli inglesi a rischiare forse di più dalla Brexit in termini di occupazione. Lo studio di Leuven ha ad esempio stimato 140 mila posti persi in Inghilterra in caso di uscita soft e 526 mila nel caso di hard Brexit. Quest’ultimo è un numero in linea con l’analisi stilata dal Ministero del Tesoro inglese all’indomani della decisione sul referendum) e con lo scenario derivante anche dalla perdita dei fondi europei per la ricerca, l’innovazione e la creazione di imprese. Certo, sia Bruxelles sia Londra stanno lavorando e allungando i tempi proprio per evitare lo scenario peggiore: dei contraccolpi inevitabilmente ci saranno, ma bisogna aspettare e vedere perché come non esistono previsioni economiche certe così non è possibile scrivere la parola fine sui legami più profondi tra Inghilterra ed Europa.